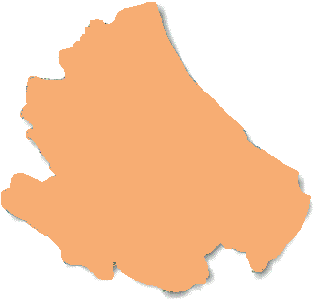 “Provincia”, nel linguaggio comune, è un termine riferito principalmente alle città più piccole del nostro Paese. E al loro hinterland. Un’accezione talvolta positiva – “vivere in provincia” si coniuga con una migliore qualità della vita (e le annuali classifiche del Sole 24 Ore o di Italia Oggi, con Trento o Mantova al top, sono lì a confermarcelo). Ma il più delle volte, specie per le province dell’Appennino, al termine s’associano, culturalmente, condizioni di “arretratezza” rispetto al modello urbano dei beni di consumo dominanti.
“Provincia”, nel linguaggio comune, è un termine riferito principalmente alle città più piccole del nostro Paese. E al loro hinterland. Un’accezione talvolta positiva – “vivere in provincia” si coniuga con una migliore qualità della vita (e le annuali classifiche del Sole 24 Ore o di Italia Oggi, con Trento o Mantova al top, sono lì a confermarcelo). Ma il più delle volte, specie per le province dell’Appennino, al termine s’associano, culturalmente, condizioni di “arretratezza” rispetto al modello urbano dei beni di consumo dominanti.
Principalmente dal dopoguerra, la nostra società è stata sempre più urbano-centrica. Se le città del Nord Italia hanno rappresentato il sogno industriale per tanti italiani fuggiti dalle campagne, specie del Mezzogiorno, Roma ha costituito l’approdo istituzionale, tra ministeri imbottiti di filiere familiari e regionali, mondi dell’informazione e dello spettacolo, terziario collegato all’apparato amministrativo. Persino il turismo ha finito per privilegiare le grandi città d’arte o le località marine rispetto all’entroterra provinciale, benché ricco di risorse naturali (si pensi allo stesso Gran Sasso), salvo qualche località sciistica ma con il Nord certamente più organizzato e blasonato rispetto al Centrosud.
E’ questa una premessa doverosa nell’affrontare quanto è successo nei giorni scorsi in Abruzzo.
Al di là delle drammatiche conseguenze di un sisma a ripetizione, che ha messo in ginocchio lembi di territorio sempre più vasti, una straordinaria nevicata – in zone comunque soggette abitualmente a difficili condizioni meteorologiche – non può certo determinare una paralisi così estesa della fornitura elettrica – fino a 200mila utenze staccate – o della circolazione stradale.
Tralasciando il dramma dell’hotel di Rigopiano o le tante responsabilità individuali, crediamo che ci sia innanzitutto un problema collettivo di approccio culturale e politico ad aree interne dell’Appennino trascurate ormai da decenni e per questo caratterizzate da condizioni di vita estremamente difficili.
Se la grande spinta all’infrastruttura viaria negli anni Ottanta (eh sì, ai tempi dell’abruzzese Gaspari, sic), pur tra tanti chiaroscuri, garantì comunque opportunità di lavoro in loco a tanti abruzzesi, le successive politiche pubbliche dei tagli orizzontali, indiscriminati, irragionevoli, secondo l’insensata logica quantitativa, ma anche la nuova attuale onda centralizzatrice dopo la moltiplicazione dei centri di spesa con i decentramenti del “federalismo all’italiana”, stanno penalizzando soprattutto le aree interne, svuotandone i servizi (da quelli postali e creditizi a quelli sanitari). Tutto ciò sta accentuando il dissanguamento demografico. Si determina, insomma, una condizione da cane che si morde la coda: decrescendo il numero dei residenti, ne risentono principalmente le attività commerciali e gli stessi servizi pubblici (si pensi alle scuole) per cui, alla fine, ne paga lo scotto l’intera economia locale. La conseguenza più logica è rappresentata dalle nuove partenze.
Interi paesi di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria condividono il triste fenomeno dello svuotamento demografico, che ha ripreso tutto il suo vigore in questi ultimi anni (con 107mila italiani finiti all’estero nel 2016, secondo i sottostimati dati ufficiali). Con conseguenze disastrose per territori sempre più estesi, per l’ambiente, per il patrimonio identitario, per la cultura locale, per i valori condivisi, per le conoscenze in ambito artigianale o enogastronomico, per quei ritmi naturali che – seppur a fatica – continuano a sopravvivere quasi esclusivamente in provincia.
A ciò si sommano i disastri compiuti dalle politiche agricole, con chiare responsabilità anche comunitarie: il settore primario è stato massacrato e ciò ha inciso non solo nell’abbandono delle terre, ma anche nei sempre più frequenti disastri ambientali. I tentativi di rilancio delle filiere locali, ad esempio con il chilometro zero, costituiscono palliativi rispetto ai diktat della globalizzazione, con punti vendita dominati da prodotti alimentari provenienti da ogni angolo del Pianeta.
C’è di più. I tanti paesi delle “seconde case”, quelle lasciate da chi è andato via, stanno vivendo un fenomeno di cui si parla poco, quello dei passaggi generazionali: se la “seconda casa” rappresenta comunque un valore perlomeno sentimentale per chi l’ha lasciata in tenera età per cercare fortuna altrove, i figli e i nipoti la vivono più come una zavorra – causa anche i crescenti costi di gestione – che non come un’alternativa alla routine di città. C’è insomma anche un enorme patrimonio edilizio delle aree interne che rischia l’abbandono.
I paesi dell’entroterra, se oggetto di seri investimenti, ad esempio infrastrutturali, potrebbero invece costituire una valida alternativa a città sempre più degradate. Cioè al recupero della qualità della vita soprattutto per pensionati. E invece domina un uso strumentale dei territori interni: ad esempio, s’è preferito scaricare qui la questione dei rifugiati, senza alcun serio piano di integrazione, alimentando l’ultimo business artificioso e temporaneo che apporterà zero benefici nel lungo periodo.
(Gi.Ca)